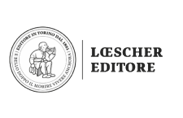inferno - Canto XXI
inferno - Canto XXI
Sono le 7 del mattino di sabato 9 aprile 1300. Quinta bolgia del cerchio VIII. I barattieri sono puniti nella pece bollente, e, quando cercano di trovare sollievo uscendo dalla plaga, i diavoli li uncinano con sadico divertimento. Tutto è nero: dai demoni alla “bogliente pegola”. Il contrappasso si legge così: i dannati portarono a compimento i loro loschi disegni nel segreto; adesso debbono soffrire infitti nel liquido bituminoso e, se emergono un solo attimo, ecco i guardiani colpirli con forcine acuminate e respingerli nel magma nero.
Chi sono i barattieri? I truffatori, specie quelli che hanno usato la loro carica politica e la posizione pubblica per arricchirsi, col cinismo di chi non ha alcun senso etico e manca del sentimento del bene collettivo.
Molti critici di peso hanno definito Dante il più attuale dei poeti non solo italiani. Questo canto, fra gli altri, ce ne dà ampia dimostrazione, anche se i protagonisti veri di esso sono i diavoli, alcuni chiamati a nome (e vedremo i significati comico-dispregiativi).
La vivacità dialogica e descrittiva, i paragoni canzonatori, la burla evidente, le metafore grottesche, la volgarità degli atti dei demoni, il crescente tessuto narrativo-farsesco, fanno di questo canto – e soprattutto dell’altro che segue – uno dei culmini della potenza descrittiva e grottesca della scrittura di Dante anche in relazione a quasi tutta la letteratura precedente e posteriore al Poema Sacro.
“Di ponte in ponte, parlando di cose «che la mia comedìa cantar non cura» (v. 2), giungemmo alla sommità, quando ci arrestammo per osservare l’altra “fessura” (vallone o fenditura) orrendamente oscura”. Ed ecco un parallelo fra la bolgia catramosa e «l’arzanà de’ Viniziani» (darsena o arsenale), in cui d’inverno i Veneziani aggiustano le loro navi: chi fabbrica una nuova imbarcazione, chi ristoppa i fianchi a quelle danneggiate e vecchie, chi opera per rafforzare la poppa e la prua; altri esperti costruiscono remi etc. Dante dà prova di conoscere con esattezza quei mestieri inerenti le vie del mare, usando parole precise, anzi tecnicamente esatte (“proda”, “terzeruolo”, “artimon”, “sartie”, etc.). Ecco, la pece nera bolliva in quel luogo infernale come nell’arzanà de’ Viniziani, ma non per opera umana e del fuo
co, bensì per prodigio divino. Dante vedeva solo le bolle gonfiarsi e ricadere com- presse, ma nessun’anima. Invece, il Duca lo spinge a guardare «un diavol nero/ correndo su per lo scoglio venire./ Ahi quant’elli era ne l’aspetto fero!/ e quanto mi parea ne l’atto acerbo,/ con l’ali aperte e sovra i piè leggero!» (vv. 29-33). Questo demonio portava in spalla un barattiere, il cui corpo penzolava all’in giù mentre il diavolo lo teneva per il tendine del piede a guisa di un macellaio che appenda all’uncino una bestia da squartare. Dal nostro ponte proferì: Ehi, Malebranche, ecco uno dei magistrati di Santa Zita, cioè un lucchese; affondatelo nella pece, perché io torno in quella città che è piena di questi ladroni, ad eccezione di Bonturo (definito dal Buti grandissimo barattiere lucchese, per cui la frase del diavolo va presa ironicamente, dato che a Lucca l’unica logica è quella del denaro e «del no, per il denar, vi si fa ita», v. 42, che significa: per i quattrini il no diventa sì). Scaraventatolo in basso, «per lo scoglio duro/ si volse; e mai non fu mastino sciolto/ con tanta fretta a seguitar lo furo». I diavoli schizzano come saette, a guisa di cani sciolti che inseguono feroci il ladro. Quel dannato si immerse nella pece e ritornò a galla lordo. Gli operatori infernali si divertono a schernire, mostrando una strana intelligenza di pungente ironia, cattiveria, canzonatura sadica. Infatti, appena il barattiere riemerge, impietosamente irridono: «Qui non ha loco il Santo Volto!/ qui si nuota altrimenti che nel Serchio» (vv. 48-49). In Lucca, infatti, era venerato un Crocifisso di legno nero nella chiesa di San Martino; il peccatore è nero, ma non è Cristo, né quella bolgia tenebrosa è il fiume Serchio, che scorre fresco presso la stessa città. Ma le parole graffianti non bastarono: fu “addentato” con più di cento uncini, con questi altri termini di burla: Qui tu devi ballare sotto la pece, e vedi un po’ se così puoi anche rubare. Come i cuochi ai loro sguatteri comandano di tenere nel brodo bollente la carne immersa con gli attrezzi di cucina, così i beffardi diavoli respingevano nella cocente broda nera chiunque tentasse di emergere.
Virgilio passò all’altro capo del ponte e «mestier li fu d’aver sicura fronte» (v. 66), cioè ci fu bisogno che mostrasse un aspetto coraggioso. Infatti, quella ciurma nera, rabbiosa, scattante, simile a cani sguinzagliati dietro a poveri straccioni, si avventa sul poeta latino, il quale ferma Malacoda rivelandogli che il cammino suo e di Dante è voluto dal Cielo. Al solito si sistema tutto; l’alterigia del gruppo vien meno, e anzi parte l’ordine di non molestare i due. Così, Virgilio invita l’allievo a muover- si da quella sorta di nascondiglio, con parole che sembrano addirittura prese dalla parlata quotidiana bassa, tanto sono insolite nel tessuto sia pur “comico” dello stile dantesco: «O tu che siedi/ tra li scheggion del ponte quatto quatto...» (vv. 88-89). Ma il vivente si accosta stretto al Maestro (lo vedremo pure in Purgatorio tal modo di fare), senza togliere lo sguardo dalla loro sembianza “ch’era non buona”.
Qui scatta un magistrale “botta e risposta”, un capolavoro di canzonatura e stizza malamente frenata fra gli operatori infernali, dove nessuno sa fino a che punto le parole dei diavoli siano veritiere o nascondano qualche trabocchetto. Ad ogni modo, non c’è altra scelta che seguire un gruppo di questi esseri neri. Malacoda, con estrema esattezza da ragioniere, ricorda che 1266 anni fa, di venerdì santo, cioè il giorno prima di questo che stiamo vivendo con i pellegrini, avvenne un terremoto. Quindi impartisce ordini, chiamando a nome i suoi scherani Alichino, Calcabrina, Cagnazzo, Barbariccia, Libicocco, Draghignazzo, Ciriatto, Graffiacane, Farfarello, il pazzo Rubicante. Sono dieci. Non sono d’accordo con la quasi totalità dei commentatori, i quali sottolineano che questi nomi accrescono l’atmosfera di terrore di cui la bolgia è piena. Essi, piuttosto, danno un senso di animalesca comicità, nonché di terrestre confidenza con le leggende del tempo dell’Autore, o con persone veramente esistite così soprannominate. Comunque, ancor oggi nel napoletano “Farfarello” significa folletto; “Cagnazzo” è il dispregiativo dell’animale amico dell’uomo ma usato da Dante in più punti dell’Inferno in modo negativo (non fosse altro per l’abbaiare che scuote i poveri dannati); “Barbariccia” sembra alludere alla fraudolenza (dice il Buti); “Ciriatto zannuto” è un porco con le zanne (la bestialità entra nella realtà narrativa soprattutto di questa bolgia); “Draghignazzo” è deformazione semantico-rappresentativa di drago, ani- male di gran lunga presente nell’immaginario popolare a quei tempi; “Rubicante” è connotazione di colore rubizzo e “Alichino” probabilmente deriva da Hellequin, numero uno di un gruppetto di diavoli detti mesnie Hellequin, etc. L’ordine dato loro è: Guardate bene intorno alla pece bollente (“panie” sono le festuche e i frustoni unti di vischio per acchiappare gli uccelli; Ariosto usa tale parola metaforicamente per l’amore: «Chi mette ‘l piè nell’amorosa pania»).
Dante, comunque, prega il Maestro di andare da soli all’altra parte, perché i diavoli digrignano i denti «e con le ciglia ne minaccian duoli» (v. 132). Ma il Maestro lo rassicura dicendo che quei versacci del viso sono rivolti «per li lessi dolenti» (v. 135: i lessi sono i dannati “bolliti”). Ma ora la comicità giunge alla farsa descrivendo anche la pesante volgarità dello strano “turpiloquio” fra diavoli: «Per l’argine sinistro volta dienno;/ ma prima avea ciascun la lingua stretta/ coi denti, verso lor duca per cenno;/ ed elli avea del cul fatto trombetta» (vv. 136-139).