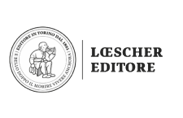Anagni
Anagni
Veggio in Alagna intrar lo fiordaliso
La parte antica di Anagni si estende lungo una via che si allunga verso la cattedrale. È questa la città dove Benedetto Caetani, papa Bonifacio VIII, fu umiliato dagli emissari di Filippo il Bello. La vicenda, nota come lo “schiaffo” di Anagni, vide Bonifacio fatto prigioniero alla vigilia dell’8 settembre 1303, quando aveva l’intenzione di scomunicare Filippo con la bolla Super Petri solio.
La vicenda è narrata da Ugo Capeto nella lunga denuncia del XX canto del Purgatorio (vv. 34-123), dove si auto-definisce, in quanto antenato dei francesi che umiliarono il pontefice, "radice de la mala pianta".
Bonifacio era stato tra i suoi maggiori nemici, ma Dante prende le sue parti, paragonando l’ingresso del fiordaliso (emblema dei re di Francia) in Anagni alla passione di Cristo:
Perché men paia il mal futuro e 'l fatto,
veggio in Alagna intrar lo fiordaliso,
e nel vicario suo Cristo esser catto.
Veggiolo un'altra volta esser deriso;
veggio rinovellar l'aceto e 'l fiele,
e tra vivi ladroni esser anciso.
(Purgatorio, XX, 85-90)
L’immagine è molto forte: Cristo è catturato (“catto”) attraverso il suo vicario e torna sulla croce in mezzo ai “ladroni” (gli scherani di Filippo il Bello che lo irridono). Quasi dimentichiamo che lo si attende nella bolgia dei simoniaci, dove il pellegrino Dante si scaglierà irosamente contro di lui e contro i papi che ne condividono il peccato. Bonifacio fu alla fine liberato dai suoi concittadini e morì a Roma.
Dante mostra nella parabola di Bonifacio il crollo dell’ambiziosa politica teocratica che voleva fissare il potere temporale nelle mani dei papi. Fu questa la causa che scatenò la reazione di Filippo il Bello. Ma questo papa è anche ricordato perché indisse il primo Giubileo, nel 1300, senza peraltro parteciparvi. Portò piuttosto gli effetti delle indulgenze capitoline ad Anagni. Qui, nel palazzo noto come di Bonifacio VIII, sono anche raccolte molteplici testimonianze dell’affronto subito. Nella sala dello Scacchiere, dove avvenne l’oltraggio, un busto del pontefice ricalcato su quello che si trova nel museo Petriano in Vaticano continua a ricevere uno schiaffo (non metaforico) e là accanto una copia del Dante degli Uffizi (di Andrea del Castagno) mostra le terzine che descrivono i fatti.
Dante ribadisce la vicenda nel XXX canto del Paradiso, dove Beatrice indica il seggio destinato all’imperatore Enrico VII ricordando l’ambiguità di Clemente V, successore di Bonifacio: gettato nel foro infernale destinato ai papi, spingerà ancora più in basso il suo predecessore di soglio e di pena.
Ecco un’ultima citazione di Anagni nelle ultime parole che Beatrice pronuncia nel poema scritto per lei:
Ma poco poi sarà da Dio sofferto
nel santo officio; ch’el sara detruso
la dove Simon mago e per suo merto,
“e fara quel d’Alagna intrar piu giuso.
(Paradiso, XXX, 145-148)

Ciociaria letteraria
Sono nati in Ciociaria molti scrittori e poeti, da Cicerone (Arpino) a Giovenale (Aquino), da Maccari (Frosinone) a molti altri. L'area è al centro del romanzo La ciociara (Alberto Moravia, 1957) da cui è stato tratto il film diretto da De Sica e adattato con Zavattini. A Cicerone è tuttora dedicato il Certamen Ciceronianum Arpinas, organizzato annualmente con la partecipazione del Comitato Dante di Arpino. Tommaso Landolfi, cantore del “fantastico”, nacque a Pico nel 1908. Qui trascorse la sua infanzia e passò come ospite anche Eugenio Montale, nel 1935. La Ciociaria ricorre in autori come Ovidio, Dante, Virgilio e contemporanei come Dino Buzzati.