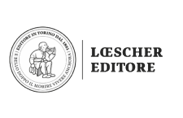Inferno - Canto XXV
Inferno - Canto XXV
Sabato 9 aprile, un po’ prima di mezzogiorno.
Siamo ancora nella VII bolgia, fra i ladri. Vanni Fucci, dopo aver parlato amara- mente al Pellegrino, rincara la dose della sua tracotanza offendendo Dio con un atto osceno delle mani rivolte in alto: Sono per te, Dio: prenditele (Dante usa la parola fiche: un gesto consistente nel mettere il pollice fra l’indice e il medio, chiudendo il pugno). A tale offesa suprema, il Poeta scrive «Da indi in qua mi fur le serpi amiche» (v. 4).
Non c’è – come in altri canti gemelli di cui ho accennato all’inizio – alcuna soluzione di continuità col ventiquattresimo. Infatti la zona è la stessa, pure il peccato punito, i mezzi della giustizia divina anche. Un rettile si avvolge a spirale intorno al collo del peccatore e un altro gli incatena le braccia. Ed ecco un’invettiva contro Pistoia, che produce figli capaci di tali depravazioni e bestemmie. Non ho trovato in nessun cerchio dell’Inferno scrive Dante, uno spirito tanto superbo contro Dio, neppure Capaneo. Di fatto, colui che cadde dalle mura di Tebe, aveva sfidato Giove, assurgendo a personaggio tragico, mentre Vanni Fucci è un bestemmiatore pazzo e bestiale.
Dopo la fuga del dannato, appare il centauro Caco, irato, pieno di “bisce su per la groppa” e un drago sul dorso, che buttava fuoco su chiunque incontrasse. Virgilio spiega all’allievo che quel gigante fu il terrore della campagna romana; la sua tana, sull’Aventino, grondava di sangue a causa delle sue vittime. Egli non sta coi suoi fratelli fra i tiranni, perché è punito qui per il furto dell’armento a Ercole, il quale lo uccise con cento mazzate, ma Caco non ne sentì che dieci (morì prima: l’ironia subentra qua e là, in questo passo in cui Dante punta tutta la sua bravura a inventare orripilanti metamorfosi fra gli esseri umani, anche se dannati, e le bestie più raccapriccianti).
Qui il Poeta trova un nuovo modo per l’incontro con le anime: siccome queste si trasformano continuamente, i tre spiriti che vogliono interloquire con Dante e Virgilio si accorgono dell’assenza di uno di loro: Cianfa Donati, mutato in strana bestia a sei zampe. Ed esso, proprio Cianfa, si fonde con Agnello Brunelleschi. L’osmosi inizia con un morso sulle gote, di modo che le diverse nature (umana e animalesca) perdono la propria identità formandone una indistinta, ibrida, repellente, inusitata, mostruosa.
La descrizione, difficile, esatta, fatta col bisturi di un chirurgo, di un dissezionatore di cadaveri, usa uno stile particolarmente suadente, raro: la paraipotassi, con la congiunzione “e” che diviene una sorta di ripresa del discorso e di sottolineatura, con qualche epitesi e rima equivoca, in una resa altissima (forse il punto culminante della fantasia creativa del Sommo Poeta).
Le due teste si erano fuse in una, annullando ogni tratto riconoscibile dei due dan- nati. Gambe, ventre, cosce e tronco formarono una figura mai veduta prima. E qui Dante si misura, come ho accennato nel canto precedente, con la potenza immaginati- va di un Lucano e di un Ovidio.
«Come ‘l ramarro sotto la gran fersa/ dei dì canicular, cangiando sepe,/ folgore par se la via attraversa,/ sì pareva, venendo verso l’epe/ de li altri due, un serpentello acce- so,/ livido e nero come gran di pepe» (vv. 79-84): i due procedono lenti per la ponderosa mole, ma un piccolo rettile nero come un granello di pepe sbuca fuori puntando verso il ventre del mostro a guisa di ramarro che va da una siepe all’altra, e trafigge l’ombelico a uno dei due, poi cade a terra. Dalla piaga del grosso animale formato dalla fusione delle due anime dannate, e dalla bocca della piccola biscia, esce gran fumo. Ed ecco un’altra spaventosa metamorfosi. Il colubro spacca la coda a forca; invece, l’ani- male ferito alla pancia saldò i piedi in uno. Gambe e cosce si unirono. La coda bifalcata prendeva fattezze che l’altra bestia aveva perdute per assumere quelle del serpe. Le braccia si ritirarono nelle ascelle; i piedi si accorciavano mentre quelli del rettile si allungavano. «Poscia li pié di rietro, insieme attorti,/ diventaron lo membro che l’uom cela,/ e ‘l misero del suo n’avea due porti» (vv. 115-117: le zampe posteriori del rettile, attorcigliate insieme, presero la forma del membro virile che l’uomo copre per pudore, e quell’altro, dal suo, aveva formato due piedi).
Dante non commenta le trasformazioni prodigiose e spaventosamente nuove; egli descrive quanto ha visto. La bravura è inimitabile. Ecco un altro esempio: «Quel che giacea, il muso innanzi caccia,/ e li orecchi ritira per la testa/ come face le corna la limaccia;/ e la lingua, ch’avea unita e presta/ prima a parlar, si fende, e la forcuta/ ne l’altro si richiude; e ‘l fummo resta» (vv. 130-135: l’animale che stava a terra sporge il muso in avanti – mentre quello che si era eretto lo ritirava verso la tempia –, facendo recedere le orecchie dal capo come la lumaca fa con le corna; la lingua, che prima era unita e adatta a parlare, diventa bifida, mentre quella del serpente si unisce, ed il fumo cessa).
Il dannato che si era mutato in rettile sibila e fugge per la bolgia; l’altro, parlando, gli sputa alle spalle (bisogna intendere questo atto non come un fatto volgare, ma uno scongiuro: al tempo di Dante si credeva che la saliva possedesse qualche antidoto contro il veleno dei colubri). Così sappiamo, dalle parole dei due peccatori attenti alla scena, che colui il quale era stato morso all’ombelico divenendo rettile è Buoso Donati; il serpente che acquista le forme di uomo è un ladro fiorentino, Francesco Cavalcanti. Dei tre compagni, solo Puccio Sciancato non era mutato. Perché? Qui bisogna “distinguere” secondo i “distinguo tomistici”: Sciancato ha commesso un furto semplice, mentre Fucci si è macchiato di un furto sacrilego; Cianfa e Brunelleschi sono stati ladri di bestiame appartenente ad altri, non pascolante allo stato brado; Donati e Cavalcanti si sono macchiati di peculato (cfr. Francesco Filomusi-Guelfi).